Alzi la mano chi guarda le serie-tv in originale coi sottotitoli d’appoggio. Se fossimo in una stanza e potessimo contarci, sono sicura che saremmo tante, specie se siamo tra i 15 e i 40 anni. Per me, che ho una passione ossessiva per i fatti linguistici, questa soluzione è deliziosa: sono quella spettatrice che manda indietro i fotogrammi finché non è in grado di riprodursi perfettamente in mente la battuta pronunciata, inflessioni dialettali comprese. Quando guardo le serie col mio compagno, che ha una formazione in arti visive, di colpo però vengo messa a parte di tutto un altro mondo d’insoddisfazione: il sottotitolo deturpa l’immagine, leggere impedisce di godere dell’inquadratura, eccetera. Se penso a chi ama le immagini come io amo le parole, d’un tratto quell’insoddisfazione diventa anche la mia. Che fare?
La risposta ovvia sarebbe affidarsi al doppiaggio. Quel doppiaggio che in Italia ha una tradizione lunghissima e una dignità altissima e che però, ultimamente, va quasi di moda denigrare. Film e serie doppiati – diciamo – banalizzano terribilmente l’originale, dialoghi scoppiettanti si appiattiscono, eccetera.
Un po’ è vero, naturalmente; ogni traduzione è un tradimento, in fondo, e lo dice una che a volte i libri li traduce. Mi chiedo però se non stiamo attribuendo ai doppiatori le responsabilità, per esempio, dell’adattamento dei dialoghi. Mi chiedo come sia realisticamente possibile aspettarsi che rimanga alta la qualità di un lavoro di traduzione e reinterpretazione che, sempre di più, deve essere eseguito dall’oggi al domani (se Orange is the new Black sta per uscire negli States la vogliamo vedere anche noi, no?). Mi chiedo quanto valgano le nostre spensierate considerazioni anglofile quando ci ricordiamo che esistono film e serie di ogni parte del mondo e non per tutte le lingue saremmo in grado di affidarci all’originale. Mi faccio, insomma, un sacco di domande.
Ho pensato di smettere di farle a me stessa e di rivolgere a qualcuno che potesse avere delle risposte più interessanti delle mie. Per questo ho fatto una chiacchierata con Franca D’Amato, attrice teatrale, direttrice del doppiaggio e doppiatrice di attrici del calibro di Tilda Swinton, Juliette Binoche e Julianne Moore. Continuate a leggere se volete la risposta ai miei dubbi amletici, ma anche solo se v’interessa sapere cosa si provi a uscire momentaneamente dalla propria pelle per diventare di volta in volta Bree van de Kamp, la protagonista di Chocolat o Narcissa Malfoy.
Punto di partenza obbligato: come si diventa doppiatrici? E, più specificamente, come lo sei diventata tu?
Si può diventare doppiatori fondamentalmente in due modi: partendo come attori oppure iniziando a doppiare da bambini. Il primo è quello che è capitato a me. Io ho fatto l’Accademia d’arte drammatica, la Silvio d’Amico, e poi tante cose: televisione, teatro, radio. Ecco, dopo un’esperienza simile puoi arrivare a imbatterti nel doppiaggio, che in fondo è un ramo della nostra professione.
A me è successo così. Ero a Trieste per lavoro e lì incontrai due esimi colleghi, Franco Zucca e Dario Penne, che facevano molto doppiaggio; mi proposero di provarci anch’io. Tornai a Roma con quell’idea in testa: erano anni che giravo l’Italia col teatro e la possibilità di una vita lavorativa più stabile non mi era indifferente. Risultato: feci qualche provino con alcuni direttori importanti presentati dai miei colleghi e, la settimana dopo, facevo doppiaggio. Avevo turni tutta la settimana, per parti da protagonista; il doppiaggio, questa via che non avevo mai corteggiato, mi ha fatto entrare subito dalla porta principale.

Jennifer Garner in “Juno” (Vanessa Loring). Doppiata da Franca D’Amato
Parli di turni: com’è una giornata-tipo nell’ambito del tuo lavoro?
Abbiamo turni di tre ore: dalle 9 alle 12, dalle 13:30 alle 16:30, dalle 16:30 alle 19:30. In una settimana puoi avere tre turni al giorno oppure uno, due alla settimana. Tutto dipende dalla parte che interpreti e da quanti progetti stai seguendo alla volta, perché di solito se ne seguono vari allo stesso tempo. Ad esempio, la settimana prossima io ho dei turni per un cartone animato, altri per una serie di avvocati, altri ancora per un film…
Ok, sei arrivata al tuo turno e inizi a lavorare. Chi c’è lì con te nella stanza? Con quali altri professionisti lavori?
In sala regia ci sono il fonico e il direttore del doppiaggio (una sorta di regista): è la persona che ha studiato il film o la serie per intero e, con quella conoscenza, ti dice di volta in volta cos’è arrivato della tua interpretazione e ti suggerisce eventuali modifiche; il grande direttore su un film importante ti può far lavorare anche per un’ora su una sola battuta.
Poi, nella sala in cui ti trovi tu, con te c’è l’assistente al doppiaggio: è la persona che ha pianificato il lavoro e che ti fa le osservazioni tecniche, quelle che riguardano il sinc. Per il resto, s’incide da soli. Prima i doppiatori coinvolti in una scena incidevano tutti insieme, mentre ora lavoriamo un po’ come polli in batteria, per via dei ritmi sempre più frenetici, ma anche per nuove richieste tecniche nell’incisione delle tracce.

Julianne Moore in “A Single Man” (Charlotte). Doppiata da Franca D’Amato
Quindi sulla tua interpretazione ci sono gli eventuali interventi del direttore e dell’assistente. E tu? Come doppiatrice, ci sono piccole modifiche / proposte che puoi fare?
Certo! Si discute, e pure animatamente! I primi anni lo facevo tantissimo: venivo dal teatro, appunto, quindi per me il lavoro era lavoro di gruppo. Poi mi sono resa conto che qui la divisione dei ruoli è più forte. Tra l’altro, il doppiatore non ha lavorato sul personaggio, lo incontra quando entra in sala e legge il copione – da attrice di teatro questo all’inizio mi lasciò basita – quindi è vero che il direttore conosce meglio il respiro generale del progetto.
Ecco, volevo giusto chiederti quali fossero le differenze principali tra doppiaggio e recitazione “a viso scoperto”…
Il tempo di lavoro sul personaggio è una differenza enorme. Una performance teatrale te la studi per un mese, te la crei; sei tu che trasformi una creatura di carta in personaggio. Nel doppiaggio, ci ha già pensato l’attore in presa diretta; il tuo è più un servizio di decodifica e mimesi, devi leggere l’interpretazione dell’attrice e capirla in modo da farle il servizio migliore, per identificarti con lei, non per scavalcarla. Questo è come la penso io; ci sono altri doppiatori che ragionano in altro modo e mantengono la loro voce sempre molto riconoscibile; sono quelle voci che riconosci sempre, qualunque ruolo facciano.
Al di là di questo, nel teatro c’è ovviamente il contatto col pubblico, che si traduce in uno stress più grande sull’immediato ma anche in una soddisfazione grande. Nel doppiaggio in fondo c’è il bello della recitazione, l’emozione dell’interpretazione, senza lo stress.
Tu hai fatto praticamente tutto quello che puà fare una doppiatrice: hai prestato la tua voce a personaggi del cinema, delle serie, dei cartoni animati. Quale campo preferisci?
Il film bello con la direttrice o il direttore bravo è una grande avventura: penso ad alcuni lavori che ho fatto su Julianne Moore, Helen Hunt, Juliette Binoche, sopratutto coi tempi più lunghi che si avevano a disposizione prima. Però le serie ti accompagnano: Bree [van de Kamp, di Desperate Housewives] è stata una sorella, mi ero affezionata a lei – ed è stato anche terapeutico: stavo affrontando un periodo un po’ complicato nella mia vita e a casa non davo a vedere le tensioni che sentivo, poi arrivavo a lavoro e trovavo Bree che uccideva il marito, dava le sue rispostacce, insomma, era proprio una liberazione!

Marcia Cross in “Desperate Housewives” (Bree Van De Kamp). Doppiata da Franca D’Amato
Che goduria, me lo immagino! Ora, una domanda in una direzione diversa: del mestiere dei traduttori si dice che l’obiettivo è essere invisibili. Mi sembra che il doppiaggio condivida questo bizzarro destino. Una simile invisibilità forzata ti pesa mai?
No, c’è solo la bellezza di servire, di onorare il lavoro dell’interprete originale. Il virtuosismo c’è comunque, ma qui è quello di arrampicare la tua voce su note che non sono tue, che non siano di maniera, che devi andare continuamente a cercare.
Tu sei anche direttrice di doppiaggio. Com’è il lavoro visto da quest’altro ruolo?
Se da attrice porto sul lavoro la mia passione, da direttrice di doppiaggio alla passione si aggiunge lo stress, specie quando ti trovi davanti a film o serie di spessore. Io da poco ho diretto Broadchurch, per esempio, che ha degli attori strepitosi – gli attori inglesi quando sono bravi sono i più bravi del mondo – e lì si che arriva lo stress.
Come faccio, coi tempi che ci vengono dati adesso, a lavorare in poche ore su un pezzo sul quale quell’attrice avrà lavorato col regista dei mesi? Come fai a decodificare quello che ha fatto l’attrice, riportarlo in italiano e ottenerlo dagli attori che hai?
Da spettatrice, in effetti mi chiedo spesso quanto sia cambiato il lavoro del doppiatore nell’era delle serie-tv. Mi sembra che i ritmi della produzione seriale incidano prima di tutto nella traduzione delle battute, che risultano spesso banalizzate rispetto all’originale; in più, immagino che i ritmi di doppiaggio minino la possibilità stessa di fare un lavoro accurato. Queste difficoltà esistono?
Esistono eccome. Le major continuano a chiedere sulla carta una buona qualità, ma subordinata all’imperativo di ricevere la massima quantità al minimo costo possibile. Noi abbiamo dei minimi sindacali, quindi la soluzione è comprimere i tempi di lavoro. In più, alcune major impongono degli standard di lavorazione nel doppiaggio che, rispetto alla professionalità che abbiamo sviluppato noi in Italia, si traducono in peggioramenti del lavoro, non miglioramenti; però dobbiamo seguirli, se vogliamo doppiare i loro prodotti, e la qualità ne risente.
Come doppiatori eravamo i più forti del mondo e lo siamo ancora, ma ora è una fatica tenere questa qualità. E l’impoverimento della qualità copre tutto il processo: le traduzioni, gli adattamenti, i tempi di recitazione che partoriscono interpretazioni di maniera…

Carrie-Anne Moss in “Memento” (Natalie). Doppiata da Franca D’Amato
Forse, insomma, piuttosto che fossilizzare il dibattito su “il doppiaggio è bene o male” sarebbe più utile spostare la discussione sulle condizioni di lavoro che impediscono di ottenere risultati alti?
Assolutamente. Se tu non dai il tempo per creare qualità, rischi di ottenere un risultato mediocre.
Spesso i film e le serie-tv, in originale, giocano con parlate dialettali, slang, cose così; una scelta che è anche nel senso di una rappresentazione inclusiva delle realtà più marginali della società. Il doppiaggio è invece quasi sempre in italiano standard. Si discute mai della possibilità di dare una resa più aderente alle particolarità linguistiche dell’originale?
La questione è sempre quella: il tempo. Di fronte a un parlato dialettale qualunque resa sarà un compromesso, quindi c’è bisogno di tempo per vagliare diverse soluzioni e scegliere quella meno dannosa. Ti faccio un esempio. Una volta abbiamo portato in teatro Pigmalione di Shaw, l’opera da cui è tratto My Fair Lady. Lì il problema enorme è lei, la fioraia, che all’inizio ha la parlata dei bassifondi londinesi. Che fai, la fai parlare come una burina? Nel film, Audrey Hepburn fu doppiata così: una scelta comprensibile, che però scaraventa nel contesto l’evocazione di luoghi che non hanno niente a che vedere con l’ambientazione reale. Noi a teatro ne provammo mille e alla fine, per farti capire, risolvemmo con una specie di dentiera che mi faceva parlare in un modo sbiascicato, storto, un po’ animalesco. Anche quello è un compromesso; a noi convinse più degli altri.
Di tutto questo si dovrebbe discutere, ma nel doppiaggio – dalle traduzioni agli adattamenti al doppiaggio vero e proprio – ormai questi tempi non ci sono. Quindi, di nuovo: se al pubblico interessa la qualità, è di questo che si dovrebbe parlare.
E qui arriviamo alla domanda esistenziale sul doppiaggio. Pasolini sosteneva che sia sottotitolare sia doppiare i film fosse fare una violenza all’immagine, ma che, mentre si può avere un doppiaggio buono, il sottotitolo non sarà mai tale. Negli ultimi anni, d’altro canto, alcune fette di pubblico preferiscono sempre di più i film in lingua originale, magari proprio coi sottotitoli d’appoggio. Da professionista – ma anche da spettatrice! – qual è il tuo parere in questo dibattito?
Guarda, anche da spettatrice per me il discorso è questo: se puoi vedere l’originale e godertelo come se fosse italiano, è la cosa migliore – però devi vederti in originale i francesi, i russi, i giapponesi, mica solo gli inglesi, o cosa fai, nella tua vita guardi solo film in inglese?
Altrimenti, il doppiaggio è una traduzione, a cui ti affiderai come sarai costretto a leggerti Proust tradotto. Ci possono essere traduzioni buone e poi schifezze, ma appunto come in letteratura. Ok, nel doppiaggio c’è qualcosa di demoniaco in più: questa voce che viene da altro corpo e si appiccica sopra un corpo che agisce… Ma mi hai capito!
Invece, da spettatrice i sottotitoli m’innervosiscono. È come dice Pasolini: sono un riassunto, spesso fatto male, che devi inseguire per tutto il film mortificandone la componente visiva. Alla fine, in entrambi i casi ovviamente stai sacrificando qualcosa e la scelta dipende da te; in questo senso, per esempio, è vero che in Italia si dovrebbero affiancare di più le due cose, lasciare più spazio alle proiezioni al cinema delle versioni originali, in modo che ognuno possa scegliere quello che preferisce. Insomma, non me la sentirei di dirti cos’è giusto; quello che penso è che però questo vale in entrambi i sensi. La levata di scudi contro il doppiaggio mi sembra invece un fare finta che una risposta giusta esista.

Mamá Imelda Rivera in “Coco”. Doppiata da Franca D’Amato
Grazie. Ti faccio le ultime due domande. Per la natura del lavoro, le donne doppiatrici esistono da quando esistono gli uomini doppiatori. Esistono disparità o discriminazioni di genere sul posto di lavoro? Essere doppiatrice e non doppiatore incide in qualche modo nella tua vita professionale?
No, secondo me no: certo, si paga sulla minore quantità di lavoro, perché la proporzione dei ruoli tra attori e attrici è di 10 a 1 e la donna attrice lavora meno dopo i quaranta, anche se su questo si sta migliorando. Tante doppiatrici per un numero inferiore di parti, dunque, questo sì, ma… No, mi sentirei di dire che non c’è nessuna differenza né nella retribuzione né nelle relazioni lavorative.
Ci racconti un momento in cui ti sei tolta qualche soddisfazione? Noi abbiamo pensato a quando hai vinto il Nastro d’argento [nel 2001, per il doppiaggio di Juliette Binoche in “Chocolat”], ma qualunque cosa tu voglia condividere è più che ben accetta!
Beh, quella vittoria è stata un bel momento. Ci atteggiamo sempre come se i riconoscimenti esterni non dovessero valere, ma è ovvio che quando arrivano sono graditissimi. Però, in generale, quando si lavora bene in sala.
Sai, Bergman, quando stava iniziando un nuovo film, scriveva una lettera alle maestranze dicendo: “Stiamo partendo per una grande avventura”. Nei grandi film, tu ti senti parte della grande avventura: ecco, questo è magnifico.



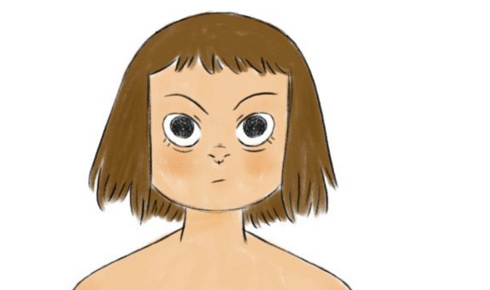



Nessun commento