La distanza a cui i morti sono andati
Dapprima non appare;
Il loro tornare sembra possibile
Per molto più di un ardente anno.Emily Dickinson (J1742 / F1781)
Sto parlando al telefono con mia mamma e lei mi sta raccontando di aver comprato dei fiori nuovi da portare al cimitero. Le chiedo quali e lei risponde ciclamini. Domani, prima di portarli, spera di riuscire a metterli in un unico grande vaso, tutti assieme.
I ciclamini mi piacciono e sono contenta che li abbia ricomprati. Non le chiedo di che colore li abbia scelti, di solito prende sempre quelli rosa (solo una volta mi ha stupita prendendoli bianchi). Questi fiori resistono bene all’inverno e non hanno bisogno di molta acqua, così se per caso non dovessimo fare visita a papà per qualche tempo, non li troveremmo appassiti.
La conversazione termina poco dopo. Il suo tono di voce era sereno, e anche il mio. Sono passati due anni, sembrerebbe che siamo riuscite a “normalizzare” la routine del cimitero e quella della burocrazia. Ma il lutto è un sentimento con un carattere discontinuo: altre telefonate con la stessa interlocutrice consteranno in dialoghi ridotti all’osso (suoi) e pesanti singhiozzi (miei).
Accettare la morte di una persona che amiamo non è per niente facile. Anche se molto dipende dalla propria cultura e credo religioso, parlando della mia esperienza la reazione istintiva è quella di continuare a sperare che, in un modo o nell’altro, la potrò rivedere ancora. E tutto tornerà come prima.
Come nell’incipit della poesia di Emily Dickinson, la mente risponde alla morte con un rifiuto: la separazione è dolorosa, come potrò mai farcela ora, da sola? Cambierà tutto. No, durerà un po’ e poi saremo di nuovo assieme. Si tratta di un meccanismo di difesa molto comune, aiuta a rallentare la paura e l’ansia della riorganizzazione.

Illustrazione di Giorgia Marras
La distanza tra me e la casa, l’ospedale, il cimitero, mi ha consentito senza sforzi, inconsciamente, di mettere in atto dei potenti meccanismi di difesa dal dolore. Una settimana dopo il funerale ero tornata a lavoro, dalla parte opposta della Pianura Padana. Rincasavo solo per firmare documenti, gustarmi (e ricambiare) qualche abbraccio, poi ripartivo.
Prima del funerale avevo mandato ogni tipo di messaggio, anche ad amiche che vivevano all’estero e volevo lo sapessero, per dire che era successo. Poi però non ho più parlato dell’accaduto con i miei amici o il mio ragazzo, per almeno un anno. Andavo ai concerti, andavo in vacanza. Ci ho messo un po’ a capire che stavo evitando volontariamente l’argomento. Non bastava averlo detto ad alta voce o averlo digitato su una tastiera: una particolare canzone alla radio del supermercato o incrociare per strada uno sconosciuto che gli somigliasse mi faceva venire immediatamente gli occhi lucidi, cedere le gambe.
Quando la madre con cui aveva un fortissimo e unico rapporto morì, il celebre semiologo e saggista francese Roland Barthes esperì un lutto terribile, puro, una siccità del cuore. Tenne per un paio di anni un diario (pubblicato poi come Journal de deuil, in italiano Dove lei non è) in cui cercò di analizzare e comprendere ciò che provava. Gli bastava un “Voilà” sentito in pasticceria per mozzargli il respiro. La sofferenza era terribile, lui però non voleva darlo a vedere:
Si può dire tanto che sono insensibile (…) quanto che sono profondamente disperato, intento a lottare per darla a bere, per non incupire chi mi sta accanto, ma che a tratti, non potendone più, “crollo”.
Ora vivo a 90 chilometri da casa dei miei. Rispetto agli anni passati sono decisamente più vicina, e per vedere la mia famiglia cerco di tornare in città più spesso che una volta. Ci sono giorni in cui penso che dopo aver parcheggiato l’auto in garage ed aver salito le scale, troverò tutti quanti in salotto a vedere il telegiornale o intenti a caricare la lavastoviglie come succedeva le ultime volte. Prima. Ma quando torno, a volte non c’è nessuno e ad accogliermi trovo soltanto il gatto, che miagola e mi chiede di sfamarlo.
Vivo un’illusione simile quando compongo il numero di telefono di casa. Non appena mi accorgo che sta suonando a vuoto, però, torno coi piedi per terra: non risponderà nessuno. Il Sirio bianco della SIP è diventato un oggetto maledetto: ha portato troppe brutte notizie e conversazioni indesiderate.
Siamo molto uniti, mia mamma, mio fratello ed io (soprattutto ora). La reciproca compagnia è certamente di conforto per tutti, ma alcune abitudini domestiche sono inevitabilmente mutate. Il lutto cambia il nostro stile di vita personale e relazionale in modo drastico. Mentre ci troviamo a provare una sensazione simile al vuoto, la morte diventa una cosa reale e spaventosa. Non solo si perde un affetto (genitore o parente, amic*, partner), ma anche un punto di riferimento. Per questo motivo lo spaesamento (assieme al rifiuto) fa parte della prima fase di elaborazione del nuovo sentimento.
“Tornando nella casa buia, dopo essermi lasciata Princeton alle spalle, mi sento come una freccia appena scoccata – verso quale bersaglio?” scrive Joyce Carol Oates descrivendo il suo ritorno a casa dall’ospedale dove è da poco morto suo marito Raymond. Il suo compagno da cinquant’anni viene a mancare in modo improvviso, e Joyce Carol Oates sprofonda nel caos del dolore e della solitudine, alleviati solo grazie alla scrittura e alla vicinanza di alcuni (pochi) buoni e savi amici.
Racconta la sua esperienza con onestà e coraggio spietati e luminosi nel romanzo Storia di una vedova. Anche per lei il telefono diventa improvvisamente criptonite:
Lo squillo del telefono mi paralizza, e quasi non riesco a respirare finché non smette. Devo resistere all’impulso di correre via, ogni volta che suona quel trillo (…) Sovente non sono dell’umore di parlare neppure con gli amici più cari.
Sembra impossibile poter sopravvivere a una persona cui vogliamo bene; essere ancora qui ci può far sentire dei disgustosi privilegiati: quella di rimanere chiusi in noi, nel nostro dolore, è una scelta legittima. Io stessa non ho ancora capito se ho messo piede fuori da questa stanza. Quando però ci si riterrà pronti ad uscirne, quel dolore potremo imparare ad accoglierlo. Senza fretta, dobbiamo dare modo alla nostra sofferenza di manifestarsi. È meglio che io sia chiara: non c’è un modo giusto di soffrire, i sentimenti non sono giusti o sbagliati mai, sono ciò che sono e basta.
Senso di colpa, devastante solitudine, impotenza, tristezza, rabbia, indifferenza per il dolore altrui, egoismo, iperattività fa tutto parte del normale processo di elaborazione. Ciò che importa è non reprimere quel che si prova. Ci pensa già abbastanza la società in cui viviamo a minimizzare la debolezza e la sofferenza, quando non a rifiutarla in toto. Concediamoci di essere vulnerabili.
Un buon gruppo di amic*, in questo frangente, può essere di aiuto: non ha risposte (non dobbiamo chiedergliele) ma può ascoltarci blaterare per interminabili minuti senza battere ciglio. Un* buon* amic* non scomparirà se, in preda a un “cattivo momento” l’avrete esasperat* e avrete parlato in malo modo. Se vorrete parlare – nel mio caso dopo un anno – non vi interromperà per dirvi che è ora di “farsi coraggio”. Ascolterà. Ci sarà e basta.
Ciascuno attraversa questa fase a modo suo. Se si renderanno necessarie terapia e medicine, si procederà anche con quelle. Un aiuto non esclude automaticamente l’altro.
Ancora Barthes:
La morte di mam.: è forse la sola cosa, in vita mia, che non abbia preso nevroticamente. Il mio lutto non è stato isterico, a malapena visibile agli altri (forse perché l’idea di «teatralizzarla» mi sarebbe stata insopportabile); e senz’altro, se fossi stato più isterico, manifestando la mia depressione, mandando via tutti, smettendo di far vita sociale, sarei stato meno infelice. E mi accorgo che la non nevrosi non è bene, non va bene.
Farsi assalire dai dubbi è normale. Le domande intasano la mente per un po’ (mente che peraltro malediremo, accorgendoci di non riuscire a ricordare bene come vorremmo alcuni dettagli che in quel momento paiono importantissimi). Quante volte avrei potuto essere più vicina, più presente, in passato? Per una persona che mi ha dato tutto, che è sempre stata presente per me, davvero non potevo fare di più? L’avrò delusa? Cosa avrà pensato di me in quegli ultimi giorni? Cosa pensavo io? Perché non me lo ricordo, forse non pensavo affatto?
Uno dei più bei consigli che Joyce Carol Oates riceve, nelle settimane successive alla morte di Ray, viene dalla sua amica Gail Godwin, anch’ella scrittrice e vedova: “Soffri, Joyce. Ray se lo merita”. E lei pensa: “È così. È assolutamente così! La mia sfida è questa: sono abbastanza forte per soffrire? E per quanto tempo?” Il tempo necessario.
Il tempo certamente cura le ferite ma non risolve, purtroppo, nulla. Barthes direbbe “non fa passare nulla, fa solo passare l’emotività del lutto”. La perdita rimane assoluta, la persona non tornerà magicamente nella nostra vita dopo che avremo imparato ad esprimere i nostri sentimenti; d’ora in poi possiamo solo ricordarla e andare avanti.
Dopo che si accetta la perdita e ci si concede di provare l’ampio spettro di emozioni legate al dolore, la terza tappa fondamentale consisterà nell’adattarsi all’ambiente ora privo della persona che stiamo piangendo. In altre parole, dobbiamo capire come organizzare la nostra vita integrando nella nostra esistenza la mancanza. Questo significa che ci saranno nuove cose da imparare, ruoli da ridistribuire, sacrifici anche economici da sostenere. Ma anche che i ricordi riusciranno ad abitare il nostro stesso spazio, senza che noi lo percepiamo come infestato e claustrofobico.
Un modo per sfuggire – per eludere – il pozzo senza fondo dell’anima è quello di tuffarmi nel lavoro. Perché il lavoro, anche se non porta sempre alla sanità mentale, è un ottimo antidoto alla follia.
Joyce Carol Oates si è salvata continuando a scrivere il romanzo che aveva accantonato prima della morte del marito, e tornando ad insegnare. La sua classe a Princeton è come un’oasi dove si può trovare rifugio da “mari in burrasca e deserti opprimenti”, il posto giusto – un luogo dove stare bene.
Anche trovare il proprio posto giusto richiede tempo; io il mio lo sto ancora cercando. A volte penso di averlo trovato tra i libri, tra i fumetti, nelle parole e nei mondi creati dagli altri che poi provo a confrontare col mio. A volte in una pizza mangiata assieme al resto della mia famiglia (gatto incluso). A volte qui, su Soft Revolution. O diventando un’amica più attenta e presente per gli altri.
A mio padre piaceva molto rivedere con cadenza regolare i suoi film preferiti: arrivava a ricordarsi quasi tutti i dialoghi a memoria. Certi giorni, come se niente fosse, li riproponeva all’interno dei suoi discorsi, sfidando me e mio fratello a riconoscere la citazione. Un luogo caro credo allora di averlo trovato conservando gelosamente quest’abitudine e continuando a vedere questi film e impararli per conto mio, sfidando altre persone a giocare con me.
Il mio posto giusto lo sto ancora cercando.




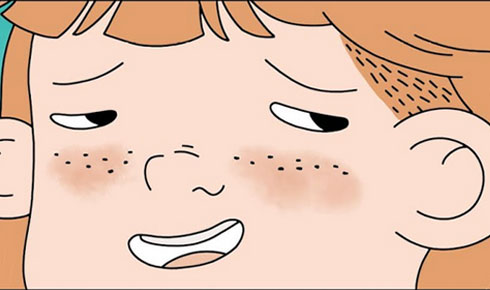


Elena
20 Dicembre
Sei anni fa è mancata la seconda persona più importante della mia vita e sinceramente ho reagito con una depressione che non voleva andarsene. Ho incontrato per caso il buddismo laico di Nichiren Daishonin. Sono sempre stata atea, dico “sempre” perché già a sei anni ero perfettamente consapevole della non esistenza di alcuna divinità. questa consapevolezza mi è derivata dalla perdita della prima persona più importante della mia vita. Attraverso questo buddismo, Ho trovato una spiegazione di vita, morte e sofferenze, che poi ho capito mi è sempre appartenuta, e un modo di vivere col quale riesco a creare valore a partire da ogni sofferenza, anche la peggiore. Non ti scrivo questo per fare proselitismo, ma per dirti che alla fine ho superato il lutto cercando di vivere come queste persone avrebbero desiderato per me, guarendo il mio inferno interiore e tappando ogni mio buco nero di consapevolezza, cercando ogni giorno almeno un motivo per apprezzare la vita. Il mio posto giusto è vivere così,dedicarmi a me e agli altri.
Alessandro Pancirolli
22 Dicembre
Solo, grazie.
Avrei voluto avere questa semplici ( ma quanti pensieri raccontano) parole per una mia amica ma non le ho trovate in quel momento.
Le manderò le tue.
Stefania
23 Dicembre
Grazie, , vorrei scrivere intorno alla morte, alle morti….